Professore di Letteratura italiana presso la Facoltà Artes Liberales dell’Università di Varsavia, autore di vari testi scientifici: “Psicopatografie. Il racconto della malattia mentale nella narrativa italiana del XXI secolo” (Peter Lang, 2023), A 40 anni dalla legge Basaglia: la follia, tra immaginario letterario e realtà psichiatrica (DiG, 2020), Beati gli inquieti (Selezione Ufficiale Premio Campiello 2021) con Neo Edizioni, lo incontriamo per parlare di follia, libertà, inquietudini
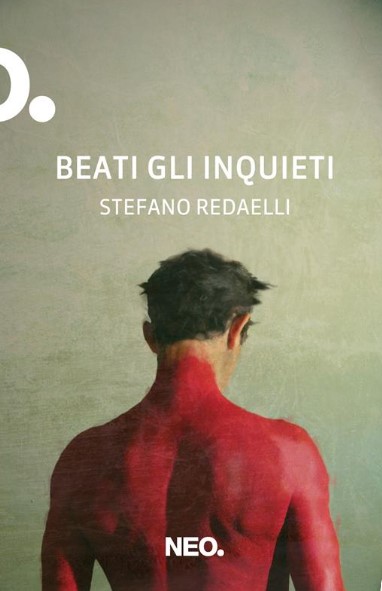
Come hai intrapreso il percorso della scrittura? Chi ti ha incoraggiato e a chi ti ispiri?
L’esigenza di scrivere è nata mentre studiavo fisica. Forse l’immersione nel mondo dei numeri, delle equazioni ha scatenato un bisogno nuovo di parole. Oltre al bisogno di padroneggiare il linguaggio della matematica – necessario per descrivere il mondo fisico (delle stelle, delle particelle) – sentivo sempre più il bisogno di crescere nella consapevolezza e nell’uso del linguaggio verbale – necessario per descrivere il mondo umano (delle relazioni, delle emozioni), non meno complesso e meraviglioso. Poi c’è stata l’esperienza di studio (un dottorato) e vita a Varsavia. Lasciare il proprio paese, a volte, fa ri-scoprire il legame con la lingua madre: scopriamo che la prima (forse l’unica) patria è la nostra lingua. E iniziamo ad amarla in un modo nuovo. Ad amarla e usarla. In quel periodo trascorrevo ore sugli autobus per andare a lavoro (Varsavia è una capitale, le distanze sono grandi). Osservavo i volti, i gesti, le abitudini dei polacchi. Ascoltavo frammenti dei loro discorsi. Non capivo niente. Dovevo immaginare. Ero così attratto da quella terra, da quelle persone, da quel mondo del tutto nuovo e diverso, che ho sentito il bisogno di iniziare a scrivere, anche per accorciare le distanze; per procurarmi una specie di “permesso letterario di soggiorno”. La scrittura era un modo per immedesimarmi, descrivere, conoscere. Da quella esigenza è nato il mio primo libro: Sull’autobus. Poema a fermate per le vie di Varsavia (Edizioni Orient-Express, 2002).
Hai un tuo “rito” per scrivere?
No. Inizio a scrivere quando sono ispirato. A volte è un’immagine, una frase, che poi scopro essere l’inizio di un capitolo. Se in quel momento non posso sviluppare l’idea, prendo appunti sul cellulare o su un foglio di carta. Poi trascrivo al computer. Mi piacerebbe essere più metodico, come quegli scrittori che si siedono ogni giorno a scrivere a prescindere dall’ispirazione. Forse un giorno imparerò a farlo. Per ora scrivo quando sono ispirato, quando ho tempo (la scrittura non è il mio primo lavoro), quando è necessario; da un po’ di tempo mi ripeto l’interrogativo di Rilke: “debbo io scrivere”?
Nel libro “Beati gli inquieti” scrivi che i folli non sono liberi e recano tristezza a parenti e amici. Chi sono i “folli” di oggi? Quanto l’indifferenza e l’abbandono isolano il folle nella propria gabbia? Seppure non liberi, possono sperare di essere felici?
In realtà scrivo che i folli sono più liberi di noi: “La loro libertà mette in crisi la nostra. Per questo gliela togliamo. Però vogliamo capire perché sono liberi di dire e fare quello che gli passa per la testa, perché loro sì e noi no”. La libertà del folle è dolente: un’onestà che si paga con l’imprigionamento. Un abbassamento di maschere (di pirandelliana memoria) che nella storia i folli hanno dovuto scontare. Per questo sono nati i manicomi. Il folle, che nell’antichità era considerato un mediatore della divinità, delle muse, una persona ispirata, nella modernità è diventato (solo) un malato, un paziente psichiatrico, oggetto di cure e controllo, in quanto la sua malattia (della quale sappiamo ancora poco, essendo la sua scaturigine complessa, multifattoriale: biologica, sociale, culturale… forse non è neanche corretto parlare di malattia, bisognerebbe parlare di disagio mentale) è considerata pericolosa.
Per questo “non andiamo mai a trovare i folli”, per questo li isoliamo; l’isolamento è una condizione ancora peggiore della malattia. Si può essere felici nell’isolamento, in una gabbia? È un’impresa ardua. Occorre trasformare l’isolamento in solitudine, in possibilità di incontro con se stessi; recuperare una libertà interiore di cui nessuna gabbia fisica può privarci. È l’esperienza di Alda Merini, che riuscì a trasformare l’inferno manicomiale in “Terra santa”, trasfigurando poeticamente il vissuto efferato del manicomio in una ricerca profonda della propria sanità, della propria poesia, a dispetto di ogni coercizione.
Gli studi che fino ad ora sono stati svolti sono sufficienti ad aiutare un “inquieto”? Cosa potrebbe aiutarlo a riemergere dal baratro?
Credo che nessuno studio, nessuna medicina, nessuna terapia possa sostituirsi alla cura della relazione, o, meglio: alle relazioni di cura. Non c’è niente di più terapeutico della fiducia, dell’accettazione, dall’amore verso ogni inquieto, che non vuol dire necessariamente malato. L’accoglienza dell’altro, del folle, del diverso da noi non è solo un gesto di amore o filantropia o magnanimità. Accogliendo l’inquietudine altrui, accogliamo la nostra, spesso nell’ombra, che richiede di essere ascoltata, accolta. Di questo parlo in Ombra mai più (che è il seguito dei Beati gli inquieti). Cito dall’Epilogo: “L’unica cura è prendersi cura: di sé, di chi ci sta vicino. Non si può fare altro per guarire, forse non serve neppure”.
A quale capitolo o personaggio del tuo libro sei più legato? Perché?
A Marta: è il personaggio più leggero. Si muove come una farfalla; è anche una rappresentazione poetica dell’effetto farfalla (per tornare alla fisica) ovvero della teoria del caos. Un battito d’ali di una farfalla a Varsavia (per esempio) può provocare un tornado a Roma. Questo ci insegna la fisica non lineare. E non è una metafora. I sistemi complessi non sono prevedibili, pur rispondendo a precise leggi fisiche. Così, forse, i folli. Agiscono secondo precise leggi, che sembrano assurde, strane, ma sono solo complesse. Marta incarna la leggerezza e la poesia: inventa filastrocche, canzoni, gioca a nascondino con i fiori. Ci si chiede, leggendo Beati gli inquieti, come sia finita in una casa di cura. La sua storia, la sua voce, ci interrogano profondamente, disarmandoci. Marta è un personaggio così importante nel romanzo da essere l’unica a raccontare in prima persona, nei capitoli a lei dedicati, che portano il suo nome. La narrazione, per il resto del romanzo, è portata avanti in prima persona dal narratore protagonista, Angelantonio Poloni.
Erlon per PassaParola Mag











