Vera Gheno è una voce autorevole nel panorama linguistico italiano. Sociolinguista, traduttrice e divulgatrice, ha collaborato per anni con l’Accademia della Crusca e ha pubblicato numerosi saggi sul rapporto tra lingua, società e identità. Conosciuta per il suo lavoro sul linguaggio inclusivo e il ruolo della lingua nella società, la Gheno ci aiuta a riflettere su come parliamo, scriviamo e — in fondo — pensiamo. Qualche mese fa, poco prima della conferenza “Il linguaggio neutro dal punto di vista del genere. Comunicazione istituzionale e produzione normativa dell’UE” tenutasi in Lussemburgo, abbiamo avuto il piacere di incontrarla. Con lei abbiamo esplorato come le parole costruiscono identità, relazioni e cultura

Partiamo da te. Quando hai capito che la lingua sarebbe diventata il tuo strumento di lavoro e di passione?
Mi piacerebbe dire che c’è stato un momento preciso, una sorta di illuminazione, ma non è così. Mio padre è linguista, un filologo ugrofinnico, quindi si occupava di tutt’altro, ma sono cresciuta in un ambiente in cui i discorsi metalinguistici, le riflessioni sulle lingue, erano all’ordine del giorno. In quel senso, probabilmente, la mia strada era già in qualche modo segnata.
Detto questo, non l’ho abbracciata subito. Per me la lingua è sempre stata una parte intrinseca della vita, ma non pensavo di costruirci sopra una carriera. Io volevo fare l’ingegnera: mi ero iscritta a ingegneria, forse anche in reazione a ciò che vivevo in casa. Dopo un anno e un solo esame ho capito che non era la mia strada e sono passata a lettere. È lì che ho scoperto che, tra le materie letterarie, quella che più mi appassionava era la linguistica — tutte le linguistiche possibili, in realtà!
Ho fatto tutti gli esami di linguistica immaginabili. Poi le cose sono successe in modo molto casuale: non ho mai avuto un piano preciso su cosa fare. Avevo chiaro che restare in università potesse essere una possibilità — era il modello che conoscevo — ma non mi sono mai strutturata davvero in quell’ambito.
Ho cinquant’anni e non sono “a ruolo”, anche perché mi occupo di ambiti poco definiti. La sociolinguistica di per sé ha uno statuto un po’ “bastardo”, e io lavoro in nicchie che l’accademia fatica a riconoscere, come il linguaggio digitale o inclusivo. Sono temi di frontiera, spesso poco legittimati dall’establishment.
Nonostante ciò, non ho mai avuto un atteggiamento aggressivo verso il mondo accademico — semmai è stato il contrario. Ho un rapporto complicato con l’ambiente universitario, ma continuo a collaborare nell’ambito della formazione e a lavorare molto con la società civile, enti e aziende.
È andata un po’ così per caso, o per fallimenti, come dico sempre: da ogni fallimento è nato qualcos’altro.
Sei anche traduttrice?
Sì, ho tradotto molto, anche se non mi considero una traduttrice. È cominciato per caso: a mio padre avevano chiesto di segnalare qualcuno per la traduzione di un libro per bambini, e lui ha proposto me. Non avevo mai pensato di usare l’ungherese per tradurre, nonostante sia la mia seconda lingua. Ho sempre studiato in Italia e sono più competente in italiano, tanto che verso l’ungherese non saprei tradurre.
Da lì sono arrivate altre collaborazioni, anche con case editrici come Adelphi e Marsilio, ma la traduzione richiede tempo e io non ho mai fatto scouting: mi hanno sempre chiamata loro. L’ultimo progetto era un romanzo di mille pagine, bellissimo, ma ho dovuto rifiutarlo perché oberata di lavoro.
L’ultima traduzione l’ho fatta dall’inglese, un libro per bambini sul tema della diversità linguistica di un linguista brasiliano: in italiano è diventato La cosa più preziosa di Victor D.O. Santos e le illustrazioni di Anna Forlati, edito da Terre di Mezzo (2024).
Ti occupi del rapporto tra lingua e società. Come sta cambiando oggi il modo in cui usiamo la lingua quotidiana?
La lingua cambia come cambia la società. Oggi viviamo in una complessità cognitiva e sociale molto più alta che in passato. Globalizzazione e internet hanno trasformato non solo la comunicazione ma la percezione stessa del linguaggio.
Anche chi non studia la lingua ora si rende conto della sua potenza: la lingua costruisce potere, disegna gerarchie, discrimina o include. È un bene che ci sia maggiore sensibilità, ma il problema è che spesso queste riflessioni avvengono nel vuoto, perché a scuola non si affrontano i meccanismi sociali e politici della lingua. Si insegna poco cosa fa una lingua, a cosa serve, come crea dislivelli di potere.
Io cerco di lavorare proprio su questo: aiutare le persone a capire che la lingua ci plasma, ci apre o chiude possibilità, può marginalizzarci o renderci più forti.
Un esempio è l’italiano degli emigrati, conservativo e affascinante nella sua evoluzione: crea forme ibride, parole contaminate da altre lingue, varietà nuove e vive. Da un punto di vista normativo sono “errori”, ma da quello linguistico sono fenomeni interessantissimi.
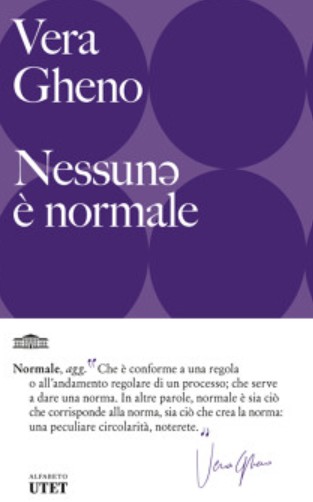
Nel tuo libro “Nessunə è normale” ( Utet, 2025 ) parli del dubbio come valore. Perché nella nostra società sembra invece qualcosa di negativo?
Viviamo in un tempo in cui il dubbio è percepito come un errore, e l’errore come una colpa. Eppure solo chi si interroga cresce davvero. Socrate lo sapeva bene: sapere di non sapere è la base della conoscenza.
Siamo abituati a concentrarci solo sul risultato e non sul processo. Ma è nel processo che nasce il progresso cognitivo: attraverso il dubbio e l’errore.
Il mio compagno ha scritto un libro sui grandi errori della scienza: quasi tutte le scoperte fondamentali sono nate da sbagli. Il punto è imparare a vedere l’errore come una tappa del pensiero, non come una sconfitta.
In che modo la lingua e le parole possono escludere o includere?
Le parole escludono quando definiscono le persone non nel modo in cui loro desiderano essere definite, ma nel modo in cui qualcun altro sceglie per loro. Avere il potere di nominarsi è fondamentale. Per esempio, le persone con disabilità chiedono di essere chiamate così, “persone con disabilità”, e non “disabili”, perché nel secondo caso l’identità si riduce alla condizione. Nel mondo anglofono si parla di disabled person, “persona disabilitata”: non è la persona a essere un problema, ma la società che non riesce ad accoglierla. Lo stesso vale per parole come migrante, immigrato, expat: un bianco che si trasferisce a Singapore è un expat, non un migrant, anche se economicamente lo è. Le parole riflettono le disuguaglianze di potere più di quanto immaginiamo. Chi ha potere sociale o economico ha anche il potere di nominare gli altri, e spesso questo potere linguistico è fonte di esclusione.
Come possiamo smontare questi stereotipi linguistici e rendere la lingua più consapevole e democratica?
La chiave è la consapevolezza. Come diceva Tullio De Mauro, non c’è cittadinanza attiva senza educazione linguistica. Se non capisci come la lingua costruisce il mondo, diventi un cittadino manipolabile.
Purtroppo la scuola non dà ancora gli strumenti per ragionare su questo. E poi — diciamolo — finché lavorare a scuola sarà considerato un ripiego e sottopagato, non avremo mai una formazione linguistica adeguata. Servirebbe una riforma radicale che valorizzi i docenti e rimetta la lingua al centro della formazione civica.
Come far capire, anche a chi non se ne occupa, che riflettere sulla lingua riguarda tutti?
Basta mostrare che è possibile. La riflessione linguistica non è un lusso da specialisti: è nelle parole che usiamo ogni giorno. Basta ragionare su come definiamo le cose.
Per esempio, nella discussione sulla GPA puoi dire “utero in affitto” o “gestazione per altre persone”: la scelta delle parole rivela già il tuo punto di vista etico.
Oppure nei titoli dei giornali: “cinque marocchini investono donna” non è lo stesso di “auto investe donna”. Piccole scelte lessicali che cambiano la percezione della realtà. Anche il modo in cui usiamo diminutivi o definizioni (“il ragazzo di 21 anni” ma “la donna di 21 anni”) dice molto su ruoli, responsabilità e pregiudizi. Insomma, servirebbe più attenzione linguistica collettiva: è il primo passo per una società più equa.

Si può imparare a usare la lingua con cura senza aver paura di sbagliarla?
Sì, sbagliando. Concedendoci di sbagliare.
Penso soprattutto alle donne, che spesso non si propongono o non si espongono per timore di non essere perfette. È la cosiddetta “sindrome dell’impostora”: ci hanno insegnato a non sbagliare mai. Ma l’errore non è una tragedia: va normalizzato.
Gli errori possono essere occasioni di crescita, se impariamo a riconoscerli e correggerli. Io stessa sbaglio spesso, soprattutto nel relazionarmi con persone molto diverse da me. Quando me lo fanno notare, chiedo scusa e cerco di correggermi. Essere una persona seria, per me, significa ricordarsi dell’errore e non ripeterlo. È così che si cresce, anche linguisticamente.
Perché il linguaggio inclusivo suscita tanta resistenza?
Perché le persone fanno fatica a cambiare. C’è una resistenza di fondo: non ci piace sentirci dire che finora abbiamo sbagliato.
Inoltre, la lingua è un elemento identitario fortissimo: toccarla significa toccare l’identità stessa delle persone. Quando chiedi di sostituire una parola, stai chiedendo anche di rivedere una parte del proprio sé.
Poi, siamo tendenzialmente ego-referenziali: se un tema non ci riguarda da vicino, ci sembra irrilevante. Molti cambiano atteggiamento solo quando una questione entra nella loro vita — per esempio quando un familiare diventa disabile, o una nipote si dichiara non binaria. Allora, improvvisamente, ciò che sembrava un capriccio ideologico diventa concreto, personale, vitale. E lì, finalmente, si capisce che il linguaggio non è una questione teorica: è una questione di vita reale.
Intervista di Paola Cairo











